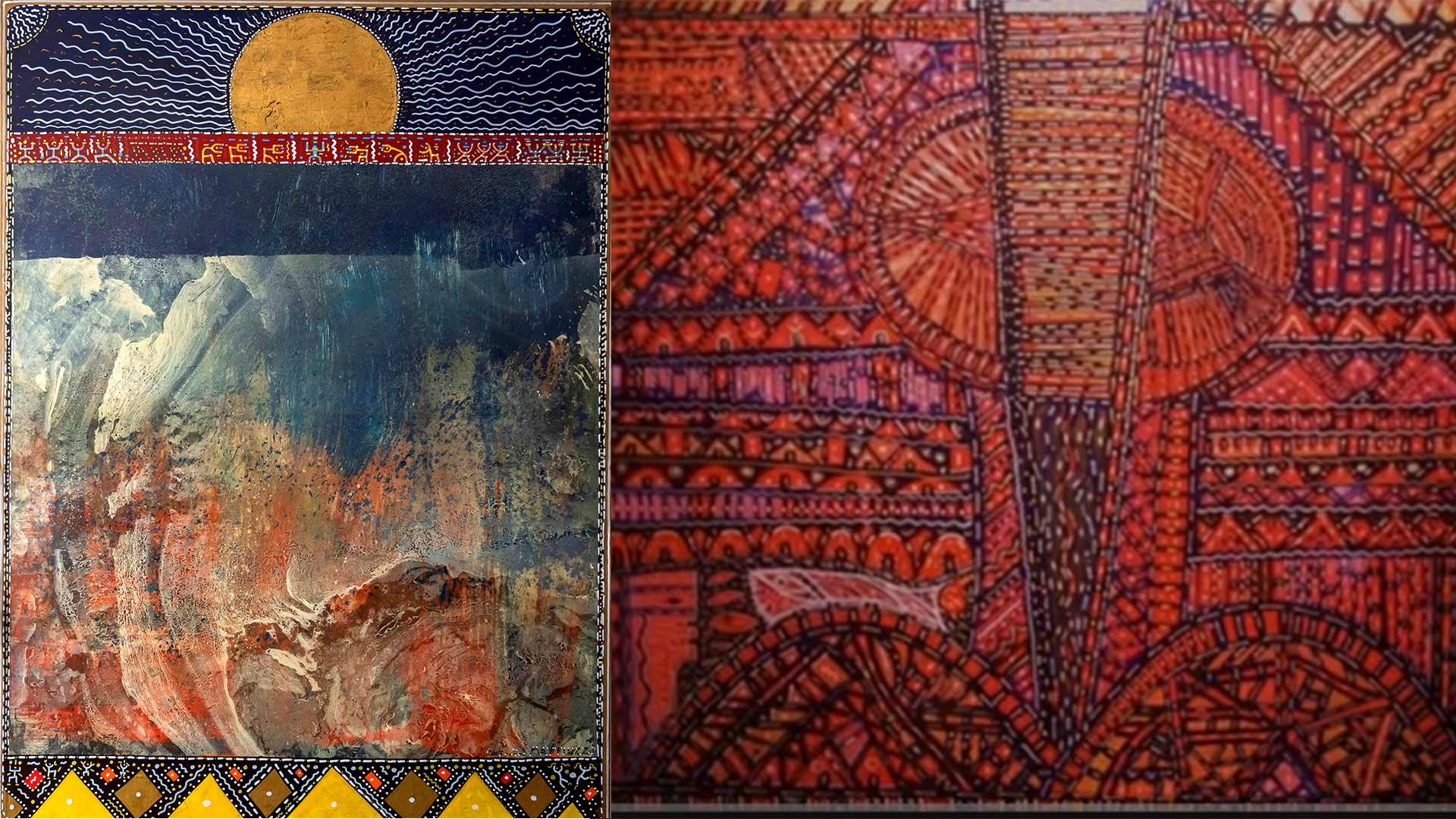Un vecchio detto sostiene, giustamente, che la talpa della storia continua a scavare per poi riemergere quando vuole lei. è un modo per dire che il tempo passa, non c’è nulla di immutabile. Anche se ci sembra che le cose rimangano tali, in realtà il cambiamento è sempre dentro di noi e intorno a noi. E prima o poi ci troviamo a doverci fare i conti. Più rimandiamo e peggio è.
è una prospettiva che vale anche per la nostra autonomia, un sistema normativo faticosamente conseguito 52 anni fa, dopo un percorso durato decenni per sanare una serie di problematiche manifestatesi nella prima parte del secolo scorso e culminate con gli anni tragici della seconda guerra mondiale. Da allora lo statuto di autonomia è rimasto tale, a parte una serie di correttivi giunti più a regolamentare più che a modificare le regole del gioco, nonostante il fatto che negli ultimi 15 anni ci si sia posti a più riprese la questione di una necessaria revisione, legata alle grandi trasformazioni sociali e politiche sopraggiunte.
I primi tentativi di operare dei cambiamenti significativi nello statuto si sono incagliati, com’è noto. I delicati equilibri e le motivazioni legate al consenso dei partiti, sempre più difficile conquistare e conservare, hanno spinto a prendere tempo. Ma – a giudicare dalle cronache – tale revisione del quadro normativo è tornata nei giorni scorsi a manifestare la sua grande urgenza.
I cambiamenti demografici, il mercato del lavoro in sofferenza, l’inesistenza di un’efficace politica per la casa, il sovraffollamento turistico, impongono ora come mai l’individuazione di un nuovo paradigma. E le contraddizioni emerse nelle ultime settimane riguardanti i più giovani, la loro formazione, e più in generale il loro futuro indicano un’urgenza rispetto alla quale non possiamo più tergiversare. I temi dello ius scholae per i ragazzi con background straniero ma nati in Italia, la proposta di “classi speciali” nelle scuole pubbliche composte da soli “stranieri”, l’abbandono scolastico record a livello nazionale, i costi spropositati a cui sono sottoposte le famiglie degli studenti universitari a Bolzano, e – non ultima – la fuga dei giovani più in gamba non più in grado di costruirsi il destino in Alto Adige, impongono a mio avviso la convocazione di una sorta di “stati generali” del… nostro futuro, che coinvolgano tutte le articolazioni del nostro finora tanto decantato modello altoatesino. La talpa sta già scavando da un bel pezzo…
Autore: Luca Sticcotti